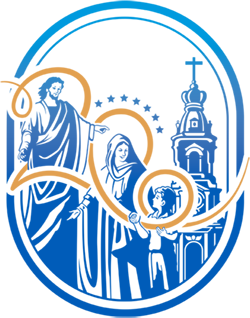1. Il nome nel sogno dei nove anni
Se proviamo a vedere in filigrana il tema del “nome” nel sogno dei nove anni, si nota, anzitutto, l’apparizione dell’uomo venerando con la faccia luminosa che Giovannino non riesce a guardare perché accecato. L’uomo nobilmente vestito di bianco mette fine al violento battibecco tra i fanciulli che ridevano e bestemmiavano e il piccolo Giovanni. Il personaggio misterioso in modo perentorio lo chiama per nome e gli impone un ordine. “Egli mi chiamò per nome”: è un richiamo biblico fondamentale, quando Dio chiama per nome affida sempre una missione (Abramo, Mosè, Samuele, Maria, Pietro, Saulo…). Sta ad indicare che l’iniziativa è sempre di Dio che per primo pronuncia il nome e fa esistere. “Dio disse luce e la luce fu”, Dio chiama per nome Giovanni Bosco e gli indica il Sistema Preventivo “non con le percosse, ma con la mansuetudine e la carità dovrai guadagnare questi tuoi amici”. Dopo aver pronunciato il suo nome e avergli indicato una missione, a questo punto, Giovanni Bosco sente l’esigenza di conoscere il nome. Per ben due volte egli domanda: “Chi siete voi che mi comandate cosa impossibile?” “Ma chi siete voi, che parlate in questo modo?”. È proprio dell’uomo conoscere, interrogarsi, porsi domande a partire dalla realtà, capire… anche per Giovanni è così. Pur essendo piccolo, ha l’intelligenza pronta e sveglia e il desiderio di capire chi è il personaggio misterioso che gli chiede una cosa apparentemente impossibile. La risposta del personaggio luminoso rispecchia la pedagogia divina: “Io sono il figlio di colei che tua madre ti insegnò di salutare tre volte al giorno”. La conoscenza del nome divino avverrà per Giovanni Bosco e nella spiritualità salesiana attraverso la mediazione materna di Maria. Come è avvenuto per l’incarnazione del Verbo, dove è stato necessario il suo “eccomi”, così per conoscere, entrare in relazione, sperimentare la forza di Gesù è necessario passare attraverso sua madre Maria. E ancora questa conoscenza avviene nella preghiera attraverso il richiamo molto delicato della preghiera dell’Angelus tre volte al giorno in una società contadina. Il mistero del nome va domandato alla Madre, così conclude il personaggio che sparisce dalla scena: “Il mio nome domandalo a mia madre”. Nella storia di don Bosco quanto è vera questa affermazione: la preghiera accorata davanti alla Madonna delle grazie a Chieri per comprendere la sua vocazione, l’indicazione del luogo del martirio dei Santi Solutore, Avventore e Ottavio perché lì fosse costruita la basilica di Maria Ausiliatrice, la comprensione del sogno con le lacrime agli occhi il 16 maggio 1887 davanti all’altare di Maria Ausiliatrice nella Basilica del Sacro Cuore. Capire il nome, conoscere il mistero che lo sottende, conoscere Gesù non è un’operazione puntuale che avviene una volta nella vita, quanto piuttosto è frutto di un processo continuo che ha un inizio, dura tutta la vita e cresce fino alla piena maturità di Cristo, finché non sia formato in voi (Gal 4,19).
2. Il nome nella Bibbia
Nella Bibbia l’imposizione del nome è l’affermazione caratteristica di una persona (Adamo chiama la sua donna issah perché tratta da is…). In tutto il mondo semitico il nome è la realtà stessa di una cosa, la conoscenza del nome comporta una specie di potere sull’essere di cui si conosce l’essenza e l’energia. Il famoso testo in cui Dio rivela il suo nome è contenuto nel capitolo 3 del libro dell’Esodo. Dio non si rivela con un sostantivo ma con un verbo (hjh, “essere, divenire, continuare ad essere). Si configura, così, il tetragramma sacro e impronunciabile da parte degli Ebrei (JHWH). In realtà il testo di Es 3,14, più che una definizione e rivelazione del nome divino, contiene una negazione di rivelazione. “Io sono colui che sono” è forse l’affermazione dell’inconoscibile essenza di Dio più che la definizione dell’eternità di Dio (“Colui che è sempre”) o della sua fedeltà (“Colui che è sempre fedele”) o addirittura della sua aseitas come voleva la filosofia cristiana classica. Tuttavia, questo appellativo “io sono” non è vuoto perché evoca il punto esatto in cui Dio si rivela: la storia dell’Esodo nella quale Egli si presenta come liberatore e salvatore. Per dirla con Martin Buber si potrebbe tradurre con “Io sono presente, lì dove sarò presente… io sono presente sempre”.
3. La storia di Mosè (Es 3,1-10; At 7,30.31)
Che cosa fa? La prima cosa che fa Mosè è meravigliarsi. Stando là nel deserto, mentre pascola il gregge del suocero, vede un po’ lontano un roveto che brucia e gli sembra che continui a bruciare senza consumarsi. Mosè, che ha 80 anni, è capace di meravigliarsi di qualche cosa, di interessarsi a qualcosa di nuovo: un roveto ardente che brucia ma non si consuma. Avrebbe potuto dire: «C’è del fuoco; è pericoloso per il gregge se il fuoco si allarga; andiamo via, portiamo le pecore lontano». Oppure avrebbe potuto dire: «C’è qualcosa di soprannaturale; è meglio non farsi prendere in trappola; partiamo e lasciamo che i più giovani, quelli che hanno più entusiasmo, se ne interessino: io ho già avuto le mie esperienze e mi basta». Invece «Mosè si meravigliò», cioè si fece prendere da quella capacità, che è propria del bambino, di interessarsi a qualcosa di nuovo, di pensare che c’è ancora del nuovo. Dunque, Mosè si meravigliò e invece di non badarci ed andarsene, «si avvicinò per vedere», il testo dice molto di più che «vedere»; indica infatti il nous (katanoesai), la mente, quindi guardare, considerare, riflettere, cercare di comprendere, ecc. Qui si vede la libertà di spirito raggiunta da Mosè attraverso la purificazione. Se fosse stato un uomo amareggiato e rassegnato, si sarebbe limitato a concludere: «Una cosa strana, ma non mi riguarda». E invece no: vuol capire, vuol vedere di che si tratta. Ecco un uomo vivo, anche se vecchio. «Mosè disse tra sé: “Voglio avvicinarmi a vedere questo grande spettacolo, perché il roveto non brucia» (Es 3,3). Il testo greco ha: ti oli? « come mai? ». Mosè è un uomo che lascia emergere le domande in se stesso; non è più l’uomo che ha già tutto sistemato e catalogato, che ha capito tutto; è un uomo ancora capace di porsi delle domande che esigono un’attenta risposta. Si può supporre una situazione di questo tipo: nel deserto vi sono differenti pianori, uno sull’altro, e spesso bisogna fare un lungo giro per salire al pianoro superiore; Mosè si trova in un pianoro più basso con le sue pecore, vede su un pianoro più alto il roveto e dice: «Andrò su, farò il giro, voglio vedere di che si tratta». Il che significa lasciare il gregge, forse anche in pericolo, salire sotto il sole, ecc. Nelle parole «voglio avvicinarmi a vedere questo grande spettacolo», dunque, scorgiamo l’animo di Mosè; è come se Mosè dicesse: «lo sono un pover’uomo, un fallito, però Dio può fare delle cose nuove, ed io voglio interessarmene, voglio capire, voglio comprendere, voglio sapere il perché». Notate che qui ritorna la grande domanda che Mosè si era fatta per 40 anni: «Ma perché Dio ha permesso quello scacco? Perché, se ama il suo popolo, non si è servito di me per salvarlo? Perché non ha colto l’occasione che io gli davo?». Questo «perché», che Mosè ha coltivato, raffinato e purificato, ecco che emerge di nuovo di fronte a quella imprevista visione. Questo «sapere» in Mosè è qualcosa che gli cuoce dentro, è una passione che non si è addormentata, ma che anzi la purificazione ha reso più semplice, più libera. Mosè non va sulla montagna alla ricerca di un nuovo successo personale; ci va perché vuole sapere come stanno le cose, vuole mettersi di fronte alla verità così com’è.
Che cosa ascolta? Es. 3, 4-6. Dice il testo: «Il Signore vide che si era avvicinato per vedere e Dio lo chiamò dal roveto e disse: Mosè, Mosè». Mosè ascolta il suo nome. Immaginate lo shock di paura e insieme di stupore di Mosè, quando si sente chiamare nel deserto, in un luogo dove non c’è anima viva. Mosè si accorge che c’è qualcuno che sa il suo nome, qualcuno che si interessa di lui; egli si credeva un reietto, un fallito, un abbandonato: eppure qualcuno grida il suo nome in mezzo al deserto. Si tratta di un’esperienza violenta, che forse abbiamo fatto anche noi quando trovandoci in un luogo in cui credevamo di essere del tutto ignorati, d’improvviso ci siamo sentiti chiamare da qualcuno per nome. Ora Mosè si sente chiamato per nome due volte: «Mosè, Mosè». Anche Mosè sente che è giunto un momento decisivo per la sua vita: è il momento in cui deve essere veramente disponibile, senza fare gli errori della prima volta; perciò, è pieno di paura: «Cosa mi sta per capitare?». E qui Mosè ascolta qualcosa che forse non si aspettava. Lui che si era lanciato con tanto ardore per vedere il roveto ardente, avrebbe avuto piacere di sentirsi dire: «Grazie che sei venuto, che non ti sei lasciato vincere dall’amarezza»; e invece ascolta quella voce che gli dice: «Non avvicinarti, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo dove tu stai è una terra santa». Mosè, con tutto il suo ardore, cercava di fare la stessa cosa: di vedere, cioè, quel fenomeno del roveto ardente come inquadrato nella sua visuale di Dio, della storia e della presenza di Dio nella storia. E allora Dio gli dice: «Mosè, così non va; levati i sandali, perché non si viene a me per incapsularmi nelle proprie idee; non sei tu che devi integrare me nella tua sintesi personale, ma sono io che voglio integrare te nel mio progetto». Mosè, dunque, ascolta: «Non avvicinarti, togliti prima i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è una terra santa». Immaginate lo sconvolgimento di Mosè nel sentire queste parole. E. questa una terra santa? Questo deserto maledetto, luogo di sciacalli, di desolazione, di aridità, dove soltanto i banditi amano venire, dove la gente per bene non abita? Questo deserto dove mi credevo abbandonato, miserabile, fallito: questa è una terra santa? È questa la presenza di Dio? È questo il luogo dove Dio si rivela?
Che cosa intende? A questo punto Mosè capisce che cos’è l’iniziativa divina: non è lui che cerca Dio, e quindi deve andare, per trovarlo, in luoghi purificati e santi; è Dio che cerca Mosè e lo cerca là dov’è. E il luogo dove si trova Mosè, qualunque esso sia, fosse anche un luogo miserabile, abbandonato, senza risorse, maledetto, quello è la terra santa, lì è la presenza di Dio, lì la gloria di Dio si manifesta. Possiamo contemplare come Mosè ha vissuto il proprio cambiamento di orizzonte, la sua vera conversione, il suo nuovo modo di conoscere Dio. Finora Dio era per Mosè uno per il quale bisognava fare molto: bisognava fare la rivoluzione, sacrificare la propria posizione di privilegio, lanciarsi verso i fratelli, spendersi per loro, per poi essere ancora scornato e buttato via. Adesso finalmente Mosè comincia a capire; Dio è diverso: finora l’ha conosciuto come uno che ti sfrutta per un po’ di tempo e poi ti abbandona, un padrone più esigente degli altri, …più del faraone; adesso comincia a capire che è un Dio di misericordia e di amore, che si occupa di lui, ultimo tra i falliti e dimenticato dal suo popolo. Poi Mosè continua ad ascoltare altre parole: «Disse ancora Dio: ‘Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe» (Es. 3,6). Mosè ha capito che non aveva capito niente di Dio; in ogni caso, pensava che quello fosse un Dio nuovo, diverso. Ma ecco che Dio gli dice: «Sono il Dio dei tuoi padri; se tu mi avessi capito, ti saresti accorto che sono lo stesso Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe; anche con essi ho agito così». Il Signore è stato un Dio che si occupa di chi è abbandonato, di chi si sente disperato e fallito. Nei vv. 7ss continua: «Il Signore disse: “Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sorveglianti. Conosco infatti le sue sofferenze, sono sceso per liberarlo dalla mano dell’Egitto e per farlo uscire da questo paese, verso un paese bello e spazioso dove scorre latte e miele. … Ora il grido degli Israeliti è arrivato fino a me ed io stesso ho visto l’oppressione con cui gli Egiziani li tormentano». Com’è attenta la dizione, tutta in prima persona: «Ho visto, ho sentito, conosco, sono sceso, ecc. …» e così anche l’implicito rimprovero per Mosè: «Tu, Mosè, credevi di essere un uomo molto colto e molto versato nella conoscenza dell’uomo; credevi di capire i tuoi fratelli, la loro miseria; credevi di essere tu a prendere l’iniziativa di capirli, e di supplicare poi me affinché́ anch’io li capissi; eppure sono io che li capisco per primo, sono io che capisco tutte queste cose, sono io che vedo e che sento. Tu, Mosè, credevi di essere il primo ad aver scoperto la bellezza della libertà, desideroso come eri di farla gustare, e non ci sei riuscito; ma tutto questo veniva da me. Tu non hai mai pensato che questa fosse l’opera mia, e invece ti sei buttato a corpo morto, pensando che l’opera fosse tutta tua, che tutto dipendesse da te. Adesso ti accorgi che io vedo, io sento…; anzi, se c’è in te qualche compassione per il popolo, questa deriva da me; se c’è in te qualche senso di libertà, sono io che te lo do; se c’è in te qualche curiosità, essa è mia».
4. Per la concretezza del cammino
Nel rituale della cena pasquale ebraica (aggadà) alcuni ragazzi che ascoltano il racconto della notte di Pasqua si comportano in modo differente. Uno di essi ha sonno; un altro invece dice: «Ma che cosa interessa a me questa storia dell’Egitto?» Un altro ancora fa domande e chiede: «Perché celebriamo questa festa e che cosa significa questa festa per noi?» È questo l’atteggiamento di Mosè e di Giovanni Bosco, che si pongono quella domanda fondamentale: «come mai?» «qual è il tuo nome?». Un bravo educatore non sa solo dare risposte, ma ancor prima sa suscitare le domande. Alcuni atteggiamenti educativi aiutano in questo arduo compito: il suscitare la meraviglia (thaumazein in greco) e il fare memoria (zakar in ebraico).